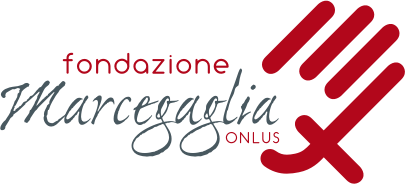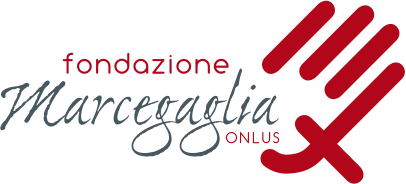La testimonianza di Giulia Fontana
Quando Giulia Fontana ha scelto di candidarsi alla Fellowship di Teach For Italy lo ha fatto spinta dal desiderio di trasformare le esperienze vissute in aula in qualcosa di più grande. Insegnante nella scuola secondaria di primo grado in provincia di Vicenza, e laureata in Storia dell’Arte all’Università di Padova, Giulia cercava una comunità con cui condividere visione e impegno per cambiare le cose.
Ogni giorno nella sua scuola di provincia incontra studenti e studentesse con storie intense, spesso segnate da difficoltà e solitudini invisibili. Per lei insegnare significa prima di tutto ascoltare: lasciarsi attraversare dalle voci, dai bisogni e dai silenzi che abitano l’aula. È da qui che inizia la vera sfida educativa, costruire uno spazio in cui ciascuno possa sentirsi riconosciuto, trovando fiducia e scoprendo il proprio valore in relazione agli altri.
Con la Fellowship Giulia ha scelto di potenziare il proprio impatto, sperimentando strumenti e approcci che mettono al centro la persona e valorizzano ogni tappa del percorso di apprendimento. Perché educare, per lei, è un atto profondamente umano, un dialogo costante tra chi guida e chi cresce, in cui entrambi imparano a guardare il mondo con occhi nuovi.

Cosa ti ha spinto a candidarti per la Fellowship di Teach For Italy e quali erano le tue motivazioni iniziali?
Mi sono candidata alla Fellowship con l’obiettivo di entrare a far parte di una comunità di persone che credono profondamente nel potere trasformativo della scuola e si impegnano ogni giorno per rendere l’educazione accessibile ed equa per tutti. Nella mia realtà di insegnante, in una piccola scuola di provincia, avevo incontrato storie intense e complesse, ragazzi e ragazze che, nonostante il loro impegno, si erano scontrati con difficoltà e fragilità e avevano faticato a trovare un loro posto nel mondo.
Quelle esperienze mi avevano portata a riflettere su come poter essere un punto di riferimento reale e su quali strategie potessero davvero aiutare i miei studenti a scoprire e valorizzare il proprio potenziale. Quando ho letto il programma di TFI, ho pensato immediatamente che fosse una grande opportunità per amplificare il mio impegno: un modo per contribuire concretamente a un cambiamento positivo e duraturo, dando voce e possibilità a chi rischia di rimanere indietro.
Quali sono le principali sfide educative che incontri quotidianamente nel contesto scolastico in cui insegni e come cerchi di affrontarle?
La principale sfida che affronto ogni giorno è ascoltare e dare spazio alle individualità dei miei studenti e delle mie studentesse. La scuola è un universo di voci, di storie, di paure e di speranze, di emozioni che vanno ascoltate e a cui va dato tempo e valore, in ogni momento. È proprio il tempo la chiave di volta attorno la quale si dipanano le strategie che io metto in campo per affrontare le mie sfide quotidiane: tempo per conoscere davvero chi ho di fronte, per ascoltare i ragazzi e le ragazze oltre le loro parole, per osservarli e comprenderne i bisogni. Tempo perché possano conoscersi a loro volta, scoprendone il proprio potenziale. Tempo per progettare lezioni che non siano solo trasmissione di contenuti, ma occasioni di dialogo, di riflessione critica e di crescita condivisa. Tempo per affrontare insieme questioni sociali e culturali, creando uno spazio in cui il sapere diventa uno strumento per interpretare e cambiare il mondo.
Durante i due anni di Fellowship, ho imparato che il tempo, se affiancato dagli strumenti giusti, può trasformarsi in un motore di cambiamento autentico. Ho acquisito competenze per progettare e pianificare un curricolo basato su traguardi di apprendimento chiari e valutabili, che non si limitano alla misurazione dei risultati ma danno valore al processo stesso. Ho imparato che progettare e pianificare significano anche pensare a come trasformare il mondo e per farlo ho bisogno di integrare le mie lezioni con le voci e le esperienze degli studenti, rendendoli protagonisti attivi del loro percorso. Il tempo che reciprocamente ci dedichiamo – in classe e fuori – è diventato così una risorsa di scambio e crescita reciproca, un’opportunità per costruire insieme una scuola più equa, consapevole e capace di dare a ciascuno lo spazio per esprimersi e realizzarsi.
La marginalizzazione sociale incide profondamente sulle opportunità educative dei ragazzi e delle ragazze. Quali iniziative o progetti, dentro e fuori la scuola, credi possano fare la differenza per contrastare la dispersione scolastica?
La scuola ha un ruolo fondamentale nel fare da argine alla crescita delle disuguaglianze, ma allo stesso tempo credo che non sempre abbia i mezzi per sostenere le sfide legate alla povertà educativa e la dispersione scolastica. Cosa può fare la differenza quindi? Tutto deve partire da un presupposto di base: l’idea di una scuola aperta, che accoglie e non respinge, un punto di riferimento attorno al quale costruire la comunità educante di un piccolo paese di provincia o di un quartiere di città.
Mi piace pensare alla scuola come al luogo delle opportunità per eccellenza, ma per esserlo veramente deve ripensare sé stessa. Riflettiamo, ad esempio, sulle potenzialità del tempo pieno, che può diventare un’occasione per sperimentare attività diverse, dalla musica allo sport, fino al teatro, coinvolgendo i ragazzi e sviluppando in loro competenze differenti. O ai progetti sul tema dell’orientamento in entrata e in uscita, che sono iniziative fondamentali per lavorare sul senso di possibilità che deve svilupparsi nella scuola, non solo negli studenti ma anche all’interno delle loro famiglie.
Quando parlo di scuola aperta, infatti, mi immagino una scuola in cui gli insegnanti dialoghino costantemente con le famiglie, in un clima di collaborazione e di condivisione di responsabilità e prospettive, creando così una comunità dove i ragazzi possano davvero sentirsi protagonisti del loro futuro.
Se dovessi descrivere la tua crescita in una parola, quale sarebbe e perché?
Se dovessi scegliere una sola parola per descrivere la mia crescita negli ultimi due anni, sceglierei la parola “mindset”. È il termine che meglio rappresenta il cambiamento più profondo che ho vissuto: non solo nel mio modo di insegnare, ma soprattutto nel modo di guardare a me stessa come insegnante e al mio ruolo nella vita degli studenti.
Grazie alla Fellowship, ho sviluppato una maggiore consapevolezza del ruolo del docente: cosa resta davvero di quello che si insegna? Come si può fare in modo che ogni studente si senta coinvolto, ascoltato e valorizzato? Questo percorso mi ha spinta a guardare il mio lavoro con occhi diversi e a riflettere sull’impatto reale che le mie scelte didattiche hanno sulla vita dei ragazzi. Oggi il mio obiettivo non è più solo trasmettere conoscenze, ma creare uno spazio in cui gli studenti siano protagonisti del loro apprendimento, in cui possano sbagliare senza paura e scoprire, passo dopo passo, il loro potenziale. Ogni lezione è quindi un’occasione per esplorare, formulare domande, cercare risposte e costruire in prima persona il proprio percorso di apprendimento in modo più consapevole e attivo.
Questo è stato influenzato anche dall’adozione di una cultura del feedback autentica e costruttiva: ho imparato infatti a non considerarlo come un semplice giudizio, ma come un’occasione di dialogo e crescita reciproca. In classe, questo si traduce in un ambiente in cui non solo io offro feedback agli studenti, ma anche loro si confrontano tra pari, imparando a valutare con attenzione il proprio lavoro e quello degli altri. Questo scambio continuo non solo li aiuta a migliorare, ma rafforza la loro capacità di riflettere, di accettare le critiche in modo costruttivo e di sentirsi parte di una comunità che cresce insieme.
Se guardo indietro a questi due anni, vedo quanto è cambiato il mio modo di essere insegnante. Oggi mi sento parte di un percorso più grande, in cui non sono solo io a guidare, ma in cui io e i miei studenti impariamo insieme, giorno dopo giorno. La cosa più bella è sapere che ogni piccolo cambiamento nella mia pratica quotidiana può fare la differenza, aiutando i miei studenti e le mie studentesse a credere nelle loro capacità e a costruire il loro futuro con più fiducia e consapevolezza.
Guardando al futuro da Alumna di Teach For Italy c’è un ambito nell’ecosistema educativo che vorresti approfondire o su cui vorresti avere un impatto particolare?
A questo punto del mio percorso lavorativo, mi piacerebbe sperimentare il mondo dell’insegnamento (o dell’educazione in generale) anche all’estero, per vedere e imparare nuovi metodi, approcci e strategie e poi tornare in Italia con nuove risorse da sperimentare. Non escludo nemmeno l’idea di lavorare per associazioni o organizzazioni del terzo settore in ambito educativo e di ricerca. Sicuramente, come Alumna di Teach For Italy, sono sicura che il legame costruito con i miei colleghi, che in questi due anni sono diventati anche amici, continuerà a essere una preziosa opportunità di confronto e crescita.
Se poi dovessi sognare in grande, mi piacerebbe tornare ai miei studi universitari di educazione museale e ricominciare a collaborare con i musei. Mi piacerebbe trovare il modo per ripensare anche questi luoghi della cultura come dei luoghi non elitari ed esclusivi di un pubblico selezionato, ma aperti al confronto e al dialogo per raccontare la storia dell’umanità attraverso l’arte, creando occasioni per costruire comunità educanti inclusive, intergenerazionali e interculturali.